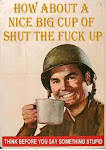lunedì 13 settembre 2010
Mumford & Sons + Fanfarlo @ Teatro dell'Arte, Triennale di Milano
Emozionante.
Energico.
Malinconico.
Esplosivo…
E potrei continuare.
Per descrivere il concerto dei Mumford & Sons al teatro dell’Arte di Milano, dovrei svuotare la mia riserva di aggettivi. Positivi, ovviamente.
In quello che, probabilmente, è stato il loro ultimo concerto in terra italica prima del nuovo album, Marcus Mumford e soci hanno fugato ogni dubbio sulla loro consistenza e sulle loro capacità di esibirsi dal vivo.
Il pubblico, numeroso e soprattutto caloroso, ha acclamato i quattro giovani londinesi per tutta la durata del concerto, dimostrando un attaccamento ed un adorazione davvero sorprendente. Così sorprendente da colpire Marcus Mumford, che credo mai si sarebbe aspettato un accoglienza così trionfale.
Ad aprire la serata si sono esibiti i sempre bravi Fanfarlo, che nel poco tempo a loro concesso hanno scaldato il pubblico, con pezzi splendidi come The Walls Are Coming Down, Harold T.Wilkins e Luna.
I Fanfarlo lasciano il palco sommersi dagli applausi, dimostrando di aver fatto colpo anche su chi era venuto solo per i loro (più famosi) concittadini.
Poco dopo è il turno dei Mumford & Sons, che attaccano subito con Sigh No More, traccia iniziale dell’omonimo album. La voce di Marcus è quanto di meglio si possa ascoltare: forte, profonda, ma anche leggera e decisa. Una meraviglia.
Ben, Ted e Winston lo spalleggiano in maniera impeccabile, a prova del fatto che sono una band solida, e non un background del comunque carismatico Marcus.
Seguono Awake My Soul e Roll Away Your Stone, pezzi che dal vivo suonano splendidamente, immergendo il pubblico in un atmosfera piacevolmente famigliare.
E’ Ben, il tastierista, a rompere il ghiaccio con il pubblico, addirittura improvvisando alcune frasi in italiano, presto imitato da Marcus e Winston.
Per chi sperava, come il sottoscritto, di poter ascoltare qualche pezzo nuovo, o magari qualche b-side, la band ha eseguito due canzoni che non fanno parte dell’album: Nothing Is Written e Lover Of The Light, intervallate dalla canzone più attesa della serata, Little Lion Man.
La loro esecuzione non smentisce la mia convinzione che si tratti di un pezzo di classe cristallina. Raramente ho assistito ad un pubblico reagire così ad una canzone, con tale entusiasmo, con tale foga e partecipazione. Le sensazioni che questo brano suscita vanno aldilà della mera esecuzione del brano stesso, comunque suonato impeccabilmente.
Dopo una dose immensa di applausi i Mumford & Sons rallentano, proponendo pezzi come Timshel e Thistle & Weeds, seguiti immediatamente da The Cave, altro brano tra i preferiti del pubblico.
Marcus e gli altri sembrano divertirsi, sembrano godersi la serata e sembrano sinceramente stupiti di come il pubblico canti insieme a loro.
Dust Bowl Dance, con Marcus alla batteria, chiude la prima parte del concerto che, a questo punto, speri non finisca mai.
Dopo la breve pausa la band annuncia che ci sarà tempo solo per una canzone, e la loro scelta (azzeccata) ricade su White Blank Page.
La loro canzone più malinconica risulta però essere la più “partecipata” dopo Little Lion Man, con tutto il pubblico a cantare parola dopo parola con i quattro menestrelli.
White Blank Page finisce, e con essa il concerto, durato poco più di un ora.
Tra i detrattori dei Mumford & Sons c’è chi dice che pecchino di originalità, e di inventiva.
Io penso l’esatto contrario.
Penso che siano, insieme a band come Fleet Foxes, Bon Iver e Grizzly Bear, la corrente musicale più interessante degli ultimi anni.
Non fanno country-folk perché è di moda, non lo fanno perché è facile e non lo fanno per assecondare i dirigenti dell’etichetta.
Lo fanno perché sono maledettamente bravi nel farlo.
E io continuo a svuotare la mia riserva di aggettivi.
Profondo.
Vivace.
Esaltante.
Grandioso.
Francesco Ruggeri
lunedì 12 luglio 2010
The Morning Benders - Big Echo

Quando metti in loop un’album intero, vuol dire che è un lavoro con i fiocchi.
Quando nell’arco di due mesi hai ascoltato quest’album 37 volte, allora capisci che si tratta di qualcosa diverso dal solito.
I Morning Benders hanno letteralmente invaso le mie playlist, al punto che quasi giornalmente ascolto il loro nuovo album, Big Echo.
Nati sotto il sole della California, baciati dal talento e osannati da buona parte della stampa specializzata ben prima di questo nuovo album, i Morning Benders avevano già fatto rizzare le orecchie un paio di anni fa, con il loro esordio Talking Through Tin Cans.
Ma è grazie a questo Big Echo, prodotto da Chris Taylor dei Grizzly Bear, che Chris Chu e compagni sono finiti sulla bocca (e sui blog) di tutti.
La traccia che letteralmente trascina l’album è la prima, ovvero Excuses. Echi di Beach Boys, armonie vocali à-la Grizzly Bear e una parte orchestrale degna degli Arcade Fire. Voilà, eccovi servita la canzone dell’anno.
A Excuses segue Promises, è un irresistibile pezzo pop-rock sincopato, all’interno del quale trova spazio la leggerezza e il respiro classico dei Grizzly Bear.
L’atmosfera “Big Sur” avvolge Wet Cement, altro pezzo che deve essere stato scritto sulla spiaggia, in una pausa tra un onda e quella successiva.
Big Echo è un album di facilissimo ascolto, di compagnia, di viaggio e suona come la colonna sonora perfetta da mettere in macchina mentre ci si dirige al mare, e sembra una splendida compilation di canzoni estive prese da tante stili diversi provenienti dalle “ere” musicali più differenti.
Le influenze sono svariate: la costa Californiana ha il suo peso nel sound di Big Echo, ma ad essa va aggiunta tutta la surf-music classica degli anni ’50 e ’60. Allo stesso tempo è presente la modernità, la freschezza e l’attualità.
Cold War, pezzo brevissimo di un minuto e quaranta secondi, è un inno alla spensieratezza e alla solarità, qualità delle quali tutto Big Echo è colmo.
All Day Light è forse il pezzo più rock di tutto il disco, senza però mettere da parte la componente atmosferica e riverberante degli altri pezzi.
E, a proposito di atmosfera, Stitches è da brividi: una canzone languida, malinconica, ma che cresce fino a diventare quasi rabbiosa, pur restando comoda nella sua aura di compostezza e di eleganza. Insomma, un pezzo magnifico.
L’album si conclude con Sleeping In, una sorta di cantico dedicato all’estate e a ciò che rappresenta, alla sua solennità e all’armonia che riesce a donare.
I Morning Benders hanno realizzato un album che mi riesce difficile non definire perfetto, almeno nel suo intento: prende tutto ciò che di buono esiste nella musica indie e pop di oggi, e lo miscela in chiave moderna con la musica pop del passato, tenendo come tema principale le calure estive e i movimenti soavi delle onde.
Peccato che noi non viviamo in California, ma grazie a questo disco, la possiamo almeno sognare.
Tracklist:
1. Excuses
2. Promises
3. Wet Cement
4. Cold War
5. Pleasure Sighs
6. Hand Me Downs
7. Mason Jar
8. All Day All Light
9. Stitches
10. Sleeping In
Francesco Ruggeri
giovedì 24 giugno 2010
The Temper Trap @ Alcatraz, Milano 16-06-2010
Era questa la sensazione che aleggiava all’Alcatraz dopo il concerto dei Temper Trap di ieri sera. Una band in ascesa vorticosa, che ormai riesce a padroneggiare il palco e l’esecuzione del proprio repertorio come chi fa questo mestiere da vent’anni.
Il gruppo spalla, che per una volta non ha deluso, erano i The Kissaway Trail, gruppo danese di giovanissimi, che cerca di seguire le orme di altri gruppi compatrioti come i Carpark North, Mew e Raveonettes, ma che ha nella fusione dei suoni simili ai Beach Boys e Sonic Youth la loro anima musicale. Poco più di mezz’ora per farsi conoscere, ma il pubblico ha apprezzato ampiamente la loro performance.
Dopo un attesa non indifferente arrivano sul palco gli australiani capitanati da Dougy Mandagi con l’aggiunta dello strumentista da tour Joseph Greer.
Senza tanti fronzoli attaccano con un intro strumentale seguita da Rest.Il pubblico risponde con un ovazione alla prima canzone che, pur non essendo un singolo, è uno degli episodi meglio riusciti del loro album d’esordio Conditions.
Fader, singolo in rotazione sia in TV che in radio, fa saltare tutto il pubblico presente grazie al suo ritmo contagioso e al suo ritornello ululato. Dougy Mandagi dimostra che la sua voce falsettata non è un risultato da studio, ma è autentica ed emozionante proprio come su disco.
Dopo la parentesi lenta di Fools, i Temper Trap suonano la superba Down River, una canzone fresca, estiva e sinceramente irresistibile che con la successiva Love Lost forma una coppia di pezzi eseguita in maniera impeccabile dalla band di Melbourne.
Man mano che il concerto continua i Temper Trap prendono confidenza con il pubblico e con se stessi, dimostrandosi musicalmente più maturi di quanto sono in realtà.Soldier On è la dimostrazione di questa maturità: un pezzo lungo, lento ma da brividi sia per interpretazione che per qualità. L’applauso del pubblico in adorazione alla fine di Soldier On è la dimostrazione di quanto le loro canzoni penetrino nei cuori dei loro (giovani) fan.
Subito dopo si giocano la loro carta migliore: il singolone spacca-classifiche Sweet Disposition, eseguito alla perfezione. Il pubblico dell’Alcatraz è in visibilio, e non si accorge di un piccolo problema di mixaggio; nel ritornello la potente voce del buon Mandagi copriva tutta la band!
A parte questo piccolo inconveniente, che comunque non ha intaccato la qualità della performance, il concerto si avvia verso la sua conclusione, con Resurrection e Drum Song a chiudere la prima parte.Acclamati a gran voce dal pubblico, in particolare il loro chitarrista Lorenzo Sillitto, i Temper Trap tornano sul palco, e Lorenzo spende addirittura qualche parola in italiano, guadagnandosi un vero e proprio tripudio di applausi.
Dougy Mandagi annuncia che suoneranno ancora due pezzi, di cui un inedito: Rabbit Hole. Un pezzo che non si discosta dallo stile del loro primo album, Conditions, ma comunque con spunti interessanti per il loro prossimo futuro.
La spettacolosa e coinvolgente Science Of Fear chiude questo concerto milanese dei Temper Trap. Seppur corto (un’ora e venti minuti, ma hanno suonato tutto l’album), questo concerto ha dimostrato appieno come i Temper Trap siano un gruppo destinato a calcare questi palchi, e palchi ben più importanti, per molto tempo a venire.
giovedì 3 giugno 2010
Blood Red Shoes - Fire Like This

Prendete un paio di ragazzi inglesi. Fategli ascoltare i Nirvana per tutta la loro adolescenza. Dategli una città noiosa e stantia come Brighton, England. E infine circondateli di loro coetanei che sanno solo parlare di calcio e risse. A questo punto l’unico sbocco che questi ragazzi possono avere, a parte l’alcolismo, è la musica.
E, fortunatamente, è proprio questa la strada scelta da Laura-Mary Carter e Steve Ansell, ovvero i Blood Red Shoes.
Con il precedente Box Of Secrets erano riusciti a crearsi una certa reputazione nell’ambiente indie Britannico, anche grazie a pezzi strepitosi come It’s Getting Boring By The Sea e I Wish I Was Someone Better.
Ora, due anni dopo Box Of Secrets, ritornano con questo nuovo Fire Like This, e fin dalle prime note le loro intenzioni sembrano bellicose: Don’t Ask inizia senza neanche lasciare il tempo di mettersi le cuffie sulle orecchie.
La velocità e l’immediatezza dei loro pezzi è sempre stato uno dei loro marchi di fabbrica, e in questo inizio di Fire Like This, i BRS non sembrano deludere.
Infatti la successiva Light It Up si presenta con un riff irresistibile di Laura-Mary Carter che infiamma un pezzo da ascoltare con il volume al massimo.
C’è da notare che rispetto all’album di esordio la sua tecnica con la chitarra ha subito dei notevoli miglioramenti e, a parte la già citata Light It Up, lo si può sentire in pezzi come Count Me Out e Heartsink.
Keeping It Close è uno di quei brani dove i BRS sembrano avere ”urgenza” di suonare, proponendo una canzone senza fronzoli, senza lustrini e melodie da checche radiofoniche.
Allo stesso modo One More Empty Chair è nel classico stile BRS: veloce, immediata e spaccatimpani.
Un punto sicuramente a favore di ogni singolo pezzo dei BRS è la batteria di Steve Ansell, che reputo uno dei migliori batteristi in circolazione, non solo per i ritmi che riesce a tenere, ma soprattutto per come riesce a cantare e a suonare così forte contemporaneamente.
Le voci di Laura-Mary e di Steve sembrano essere state concepite per cantare insieme, e la loro chimica su disco è innegabile: la riprova è Colours Fade, traccia conclusiva di questo Fire Like This, che è il pezzo migliore che abbiano mai fatto. Sette minuti di grunge, punk e psichedelia uniti in un miscuglio al limite della perfezione stilistica. Una canzone sorprendente, che mi lascia ancora più fiducioso nei confronti di questo giovanissimo gruppo.
In conclusione Fire Like This non è strutturalmente diverso dal loro primo Lp, ma suona semplicemente meglio, in ogni singolo aspetto. Non sarà mai considerato un album che ha segnato il suo periodo, ma è decisamente divertente e si fa ascoltare per tutti i suoi 37 minuti di passione.
Promossi.
A pieni voti.
giovedì 27 maggio 2010
The National - High Violet

I The National hanno raggiunto con il loro precedente album, Boxer, un successo inaspettato ma assolutamente meritato.
Forti di quel successo e del loro innegabile talento nel creare canzoni pregne di malinconica emozione, questi cinque ragazzi del Cincinnati, ma adottati da New York, hanno pubblicato il largamente atteso High Violet.
Ma come si fa a dare un seguito ad un album che la maggior parte della stampa musicale ha definito perfetto e che il pubblico ha (giustamente) premiato con tanta ammirazione?
Ecco come: rinchiudendosi in studio per rielaborare le fortunate atmosfere di Boxer ma uscendone con un suono ancora più polveroso, con testi più introspettivi e con canzoni cariche di romanticismo.
Terrible Love, il primo pezzo di High Violet, inizia con le chitarre dei fratelli Dessner in primo piano, ma è la voce profonda di Matt Berninger a dare una scossa di adrenalina. Il modo in cui narra le storie dei propri personaggi, come ne sottolinea le emozioni, è davvero unico.
Non ha una voce cristallina, ma è come si interpreta una canzone che spesso fa la differenza. Beh, Matt Berninger fa la differenza, in ogni singola strofa o ritornello che canta.
Ogni brano di questo High Violet vede i The National affrontare le differenti emozioni umane, e così come Terrible Love parla di tentazione e di peccato, Sorrow parla del dispiacere e della tristezza nel soffrire per qualcuno, con un testo da lacrime agli occhi.
Afraid Of Everyone parla della paura, abbastanza comune, di ciò che ci viene somministrato da giornali, radio e televisioni, e del timore di crescere senza una propria identità.
Bloodbuzz Ohio è un pezzo strepitoso, che evoca immagini e sensazioni uniche, e che invoglia a prendere uno zaino ed uscire di casa a godersi il sole estivo.
C’è anche il tempo per un tributo: in England Matt Berninger narra di estati piovose passate in quel di Londra, in un pezzo lento ma molto coinvolgente.
Non vorrei essere troppo influenzato dai miei gusti personali, ma questo album è sicuramente uno dei migliori che ascolteremo in quest’anno. E in quello successivo. E in quello dopo ancora.
Non si sono discostati troppo dallo stile e dal sound del precedente Boxer, e non sono caduti nel cliché del pop, della canzone sempliciotta e radiofonica.
Nessuna delle canzoni di questo album è un riempimento, nessuna è inferiore alla precedente. Non ci sono difetti, non ci sono pecche. Non c’è nulla da appuntare.
Su brani come Vanderlyle Crybaby Geeks non c’è nulla da dire, c’è semplicemente da ascoltarle e ringraziare i The National per ciò che fanno per la musica.
Tracklist:
1. Terrible Love
2. Sorrow
3. Anyone’s Ghost
4. Little Faith
5. Afraid Of Everyone
6. Bloodbuzz Ohio
7. Lemonworld
8. Runaway
9. Conversation 16
10. England
11. Vanderlyle Crybaby Geeks
Francesco Ruggeri
giovedì 20 maggio 2010
Black Rebel Motorcycle Club @ Magazzini Generali, Milano 07/05/2010
Ogni volta che vedo dal vivo i Black Rebel Motorcycle Club ho la sensazione di assistere alla performance della band più cazzuta e “cool” esistente sulla faccia della terra.
Questa impressione l’ho avuta anche in occasione della loro ultima apparizione in territorio Italiano, il 7 maggio scorso in quel dei Magazzini Generali a Milano.
Il classico traffico mi fa perdere la band di supporto, i Newyorchesi Zaza, ma quando arrivo il locale è praticamente vuoto.
Nell’arco di mezz’ora però i Magazzini si riempiono all’inverosimile, rasentando il sold out.
Peter Hayes, Robert Turner e il nuovo acquisto Leah Shapiro salgono sul palco e senza tanti fronzoli, come di consueto, attaccano subito con la potentissima e velenosa War Machine, pezzo tratto dal loro ultimo sforzo in studio: Beat The Devil’s Tattoo.
Senza un attimo di pausa si passa ad un secondo pezzo tratto dall’ultimo album: Mama Taught Me Better, che vede destreggiarsi in maniera pregevole Leah Shapiro alla batteria, cosa che stupisce il sottoscritto e tanti altri presenti ai Magazzini.
Ma al terzo brano arriva una sorpresa, una di quelle che non ti aspetteresti mai: Red Eyes And Tears, tratta dal loro album d’esordio omonimo, ed eseguita in maniera impeccabile.
Il primo singolo Beat The Devil’s Tattoo e Bad Blood chiudono una prima parte di concerto dedicata ai brani tratti dal nuovo album che , come spesso accade, rispetto all’album prendono tutta un’altra dimensione quando vengono suonati dal vivo.
L’immancabile Ain’t No Easy Way fa cantare tutti i presenti, con Peter Hayes in forma vocale davvero smagliante.
La complicata dinamica tra i due leader e cantanti del gruppo trova sul palco una sua equilibratura perfetta, nella quale Robert è lo showoff, lo spaccone, mentre Peter è il quieto e l’imbronciato. La differenza di carattere è marcatissima, ma la loro combinazione li rende una coppia che sul palco si amalgama alla perfezione.
Non c’è tempo di rilassarsi, o di tirare il fiato, i BRMC sparano un pezzo dopo l’altro, tra cui la coppia Berlin e Weapon Of Choice, tratti dal poco fortunato Baby 81.
Un classico momento lento, presente in tutti i live dei BRMC, vede Robert al piano, mentre suona un tristissimo b-side tratto da una poesia di Edgar Allan Poe, Annabel Lee.
Mentre il pubblico si asciuga le lacrime ecco arrivare una delle canzoni più attese: Whatever Happened To My Rock’n’Roll che mette a serio rischio l’integrità del locale.
Leah Shapiro e Peter Hayes si congedano, lasciando solo Robert Turner sul palco mentre imbraccia una chitarra acustica per un altro b-side fantastico: Mercy, tratto dalle Howl Sessions.
Ma da qui in poi è una discesa verso l’inferno con Conscience Killer, una spaventosa versione di Six Barrel Shotgun e una bruciante Spread Your Love.
Il concerto sembra finito, ma i BRMC trovano il tempo per un secondo encore, ricevendo uno scroscio infinito di applausi.
La cattivissima linea di basso di Stop, forse la loro canzone più famosa, da l’inizio ad un secondo encore incredibilmente intenso ed emozionante. C’è il tempo per uno dei pezzi meglio riusciti di Beat The Devil’s Tattoo, Shadow’s Keeper, che dal vivo è vibrante e sinistra come poche altre canzoni dei BRMC.
Peter Hayes annuncia che avrebbero voluto suonare ancora, ma che il locale si deve trasformare in una discoteca e che quindi devono smettere.
E’ un peccato doverli interrompere, dover fermare un live ben riuscito come questo, una band che sembra aver trovato la propria strada dopo aver seguito un percorso a dir poco tortuoso.
Come ultimo sussulto per il pubblico in adorazione, tirano fuori dal cappello Open Invitation, ghost track in Howl.
Le ultime note escono dall’amplificatore della chitarra in feedback e Robert rivolge al pubblico un sentitissimo ringraziamento. Dio vi benedica, dice.
No, Robert, Dio benedica voi.
Setlist:
- War Machine
- Mama Taught Me Better
- Red Eyes And Tears
- Beat The Devil’s Tattoo
- Bad Blood
- Ain’t No Easy Way
- Aya
- Berlin
- Weapon Of Choice
- Annabel Lee
- Whatever Happened To My Rock’n’Roll
- Mercy
- Conscience Killer
- Six Barrel Shotgun
- Spread Your Love
- Stop
- Shadow’s Keeper
- Open Invitation
Francesco Ruggeri
mercoledì 19 maggio 2010
Band Of Horses - Infinite Arms

Immaginate un viaggio in America. Un viaggio che ripercorra le radici di un popolo e di un paese così eterogeneo e complicato. Un viaggio nel quale si assaporano sapori, si vedono luoghi e si ascoltano suoni che rappresentano l’America moderna.
Questo viaggio lo si può compiere semplicemente ascoltando il nuovo lavoro dei Band Of Horses, giunti al loro terzo album, e freschi di “salto” in una major.
Spesso il passaggio da un etichetta indipendente (in questo caso la storica Sub Pop) ad una major è sempre tragico, nel senso che diventano obbligatori compromessi contrattuali e musicali, atti a compiacere un pubblico più ampio.
In questo caso però i Band Of Horses non sono cambiati, non hanno snaturato niente del loro sound tipicamente Southern Rock e sono addirittura riusciti a racchiudere in un disco tutto ciò che di buono avevano mostrato nei precedenti due lavori in studio.
Questo Infinite Arms inizia con Factory, canzone che riprende le atmosfere sognanti e delicate di tanti altri brani di Ben Bridwell & Co.
Il primo sussulto è da attribuire alla traccia numero tre, ovvero Laredo. Una canzone allegra, spensierata e con un ritmo assolutamente irresistibile. Ben Bridwell narra di Laredo, di un viaggio nel Texas, e di una ragazza che l’ha lasciato in riva ad un lago.
Le canzoni dei Band Of Horses fanno spesso riferimento a momenti di vita vissuta dei componenti della band, magari storie nate proprio sul tour bus che spesso li porta in giro per tutti gli Stati Uniti. Ed è proprio questa la loro dimensione preferita, poter girare il mondo e portare la loro musica ad un pubblico più ampio e vario.
Canzoni come Compliments e Blue Beard sembrano state scritte appunto per raggiungere un target a loro precedentemente sconosciuto.
Ma i barbuti di Seattle non si sono assolutamente persi nei meandri insidiosi del pop-rock, anzi. On My Way Back Home è la summa del talento evocativo e musicale dei Band Of Horses, che riescono sempre a creare qualcosa che non sarà nuovo, ma sempre attuale e fresco.
Ennesimo esempio di questa (personalissima) teoria è la traccia numero sette: Dilly. Un inizio di tastiere ben ritmato nasconde una canzone con un testo malinconico, nella quale le chitarre di Bridwell e Tyler Ramsey si intrecciano, narrando una dolorosa separazione.
Ci sono anche momenti di splendida e rilassatissima riflessione: Infinite Arms e Evening Kitchen vedono la voce caratteristica di Ben Bridwell in primo piano, mostrandoci un lato musicale che i BoH hanno nelle loro corde, ma che non mostrano spesso.
C’è spazio per una canzone canonicamente rock: Northwest Apartment che seppur lontanissima dal capolavoro Is There A Ghost del precedente album Cease To Begin, si dimostra un pezzo di grande intensità ed un perfetto preludio allo splendido brano conclusivo.
Bartles + James è perfetta per chiudere in bellezza questo album, che vede i Band Of Horses fare per la prima volta i conti con il dilemma della notorietà.
La cosa importante che questo Infinite Arms mette in chiaro è che questi ragazzi di Seattle con il folk e il country nel cuore non si sono venduti, anzi, sono migliorati in tutto ciò che poteva essere ritoccato, uscendone con un sound più marcato e deciso e con un album che non posso che definire splendido.
Tracklist:
1. Factory
2. Compliments
3. Laredo
4. Blue Beard
5. On My Way Back Home
6. Infinite Arms
7. Dilly
8. Evening Kitchen
9. Older
10. Trudy
11. Northwest Apartment
12. Bartles + James
Francesco Ruggeri
martedì 11 maggio 2010
These New Puritans - Hidden
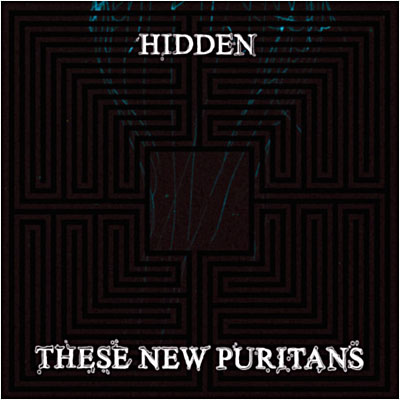
Se vi dicessi che il nuovo album dei These New Puritans è già adesso un serio candidato per album dell’anno, mi prendereste sul serio?
Certo che no. Non mi prenderei sul serio neanch’io, eppure è così.
Portando ad un livello esasperato la sperimentazione, i TNP si erano già distinti un paio di anni fa con l’ottimo Beat Pyramid.
Ma Hidden è un'altra cosa. Un altro album. Un altro posto ed un altro luogo, dove quasi nessuno osa spingersi.
Ascoltandolo si prova un continuo senso di pericolo e di intimidazione, come se l’album si ponesse in maniera minacciosa rispetto all’ascoltatore. Suoni di vetri infranti, spade sguainate e tamburi di guerra si fondono con beat elettronici veloci e potenti.
Hidden è un affascinante lavoro compositivo, che comincia con Time Xone, un corto preludio orchestrale che racchiude però in sé tutta l’essenza sperimentale dell’album.
Non ci viene lasciato il tempo di abituarci agli ottoni soffici e vellutati, che We Want War, primo singolo estratto, inizia con prepotenza la sua cavalcata di sette minuti e ventiquattro secondi, all’interno della quale i TNPS sguainano tutte le loro armi: ritmi incalzanti, suoni elettronici, suoni di lame sguainate e tamburi da guerra giapponesi. Un pezzo sconvolgente per la sua efficacia, per il coinvolgimento che provoca in chi lo ascolta e per la potenza scaturita.
Il terzo brano, Three Thousand, vede in primo piano la batteria di George Barnett, in grado di tenere ritmi velocissimi e complicati.
Mentre Three Thousand finisce riprendendo la melodia di Time Xone, si capisce già che questo sarà un album epico, destinato a scomodare paragoni eccellenti e nomi importanti, ma i TNPS, seppur ispirandosi ad una ben precisa corrente musicale, hanno creato un mix unico, che difficilmente nella musica contemporanea si era visto.
Attack Music, secondo singolo estratto da Hidden, è la summa dell’impegno profuso dai TNPS: c’è l’elettronica, c’è il rock, c’è l’avanguardia, ci sono ottoni e violini, ma soprattutto c’è pathos e c’è emozione. Questa canzone non sarà la migliore dell’album, ma è sicuramente quella sulla quale Jack Barnett e soci hanno lavorato di più.
Orion, la settima traccia dell’album, è un altro pezzo di quelli che fanno accapponare la pelle, sia per la sua intensità, che per la sua oggettiva bellezza artistica. La melodia acida e nervosa è accompagnata da un coro che si rivela allo stesso tempo inquietante e rassicurante.
Canticle, un semplice intermezzo di un minuto e dieci secondi, è in realtà un preludio per l’ultimo atto.
Drum Courts – Where Corals Lie sembra un pezzo creato appositamente per il cinema. E’ facile immaginarsi una battaglia tra due immensi eserciti, mentre i tamburi riecheggiano per tutto il campo di battaglia. E’ un ennesima dimostrazione di come la musica dei TNPS possa adattarsi a diversi ambiti artistici. Jack Barnett sussurra le parole della canzone, quasi come se non volesse rovinare una creatura già di per sé perfetta.
L’album si conclude con 5, un brano senza testo che mette in primo piano gli ottoni, con le loro note insistentemente presenti in quasi tutte le tracce di Hidden.
Seppur giovanissimi, i TNP hanno le idee ben chiare in testa: in questo Hidden non c’è la ricerca del singolo, del compiacimento, dell’idea di doversi vendere al pubblico, questa è musica scritta ed eseguita per il semplice piacere di creare arte.
Alla fine Hidden è proprio questo. Un’opera d’arte.
Francesco Ruggeri
martedì 6 aprile 2010
One month off
lunedì 1 marzo 2010
The Courteeners - Falcon

Essere considerati i salvatori dell’onore musicale Mancuniano deve aver giocato brutti scherzi ai The Courteeners.
Canzoni come Acrylic, Not Nineteen Forever e Cavorting li avevano fatti diventare, intorno al 2007, autentici idoli della gioventù di Manchester. Sono stato testimone oculare di scene di delirio nei locali della città inglese, quando alle prime note di Acrylic le ragazze iniziavano a singhiozzare e a strapparsi i capelli.
Tutto sommato St. Jude, titolo con ovvio tributo ai Beatles, era un album onesto, discreto e, preso a piccole dosi, non male. Ma già nel loro fortunato debutto Liam Fray e soci avevano mostrato una insana dose di spavalderia e di arroganza.
Dopo due anni intensi di tour, interviste e grossi palchi estivi, dopo aver dichiarato di essere la miglior band mai uscita da Manchester, i Courteeners si sono rinchiusi in studio per dare seguito al fortunato St. Jude.
Falcon, questo il nome del nuovo sforzo in studio, è un album largamente atteso, non solo dai Mancuniani, ma un po’ da tutti coloro che per Liam Fray e soci aveva speso parole di elogio. Ecco, forse stavolta le parole di elogio saranno un po’ meno, perché fin dal primo ascolto Falcon si rivela piatto, scialbo e senza idee originali.
Il primo singolo, You Overdid It Doll, è da brividi. Nel senso che è davvero una brutta canzone, soprattutto musicalmente. Un intro con un piano improvvisato, chitarra funky come sottofondo per una canzone che sembra un misto tra la dance anni ’90 e il brit-pop peggio riuscito. Eppure qualche episodio positivo c’è, ad esempio The Opener che, come suggerisce il titolo, è la prima traccia dell’album. Una canzone ambiziosa, ma che riesce a trasmettere qualcosa. Liam Fray sa cantare, ma non basta la sua verve e il suo (indiscutibile) carisma per salvare brani che mancano spesso di convinzione.
Take Over The World ha un inizio travolgente e promettente, ma altrettanto velocemente ricade su se stesso, finendo per essere un pezzo blando.
Le idee in questo Falcon ci sono, ma sembrano canalizzate davvero male. Ad esempio la conclusiva Will It Be This Way Forever? è una canzone onesta ed orecchiabile, che ricorda i successi del primo album.
Ho ascoltato molto di peggio, ma anche molto di meglio. La critica Inglese ovviamente li loda. NME li ha osannati e ha parlato di Liam Fray nei termini di “genio”.
La musica è spesso soggettiva, ma qui è difficile sbagliarsi. Era decisamente meglio St.Jude.
Almeno aveva Acrylic, che faceva strappare i capelli alle ragazze di Manchester.
E quasi anche a me.
Tracklist:
1. The Opener
2. Take Over The World
3. Cross My Heart & Hope To Fly
4. You Overdid It Doll
5. Lullaby
6. Good Times Are Calling
7. The Rest Of The World Has Gone Home
8. Sycophant
9. Cameo Brooch
10. Scratch Your Name Upon My Lips
11. Last Of The Ladies
12. Will It Be This Way Forever?
Francesco Ruggeri
martedì 2 febbraio 2010
Sydrojé - Duende

venerdì 29 gennaio 2010
Wolfmother - Cosmic Egg

I Wolfmother hanno un sacco di detrattori. E un sacco di estimatori.
I detrattori sostengono che siano un gruppo sostanzialmente falso, che suona musica copiata all’inverosimile dagli anni ’70, ai quali loro dicono di ispirarsi, senza però presentare nulla di nuovo o di interessante.
I loro sostenitori, invece, adorano il loro puro hard rock senza fronzoli, che prende il meglio da band come Led Zeppelin, Deep Purple e Black Sabbath e lo ripropone in chiave moderna, aggiungendo elementi presi da band più attuali, come Queens Of The Stone Age e The White Stripes.
I Wolfmother di questo Cosmic Egg, però, non sono i Wolfmother del precedente disco. Infatti il batterista Myles Heskett e il bassista/tastierista Chris Ross non fanno più parte della band, a causa di attriti insanabili con il frontman, Andrew Stockdale.
Dopo un periodo nel quale pensò di sciogliere definitivamente il gruppo, Stockdale decise di continuare con il nome Wolfmother, reclutando tre nuovi musicisti che lo affiancassero nelle registrazioni di un nuovo album, questo Cosmic Egg.
Quindi cosa è rimasto veramente dei Wolfmother del primo elettrizzante album?
Le radici, innanzitutto. Poi l'ispirazione, il sound e il mood, tutta roba in prestito dai seventies.
L'album inizia con California Queen, che ha un possente riff di basso che ricorda i Queens Of The Stone Age. Un bel pezzo, buono per far capire l'attitudine di questi "nuovi" Wolfmother.
Il pezzo successivo, New Moon Rising, è il primo singolo estratto. Un pezzo brutale, con un ritornello da stadio e le chitarre a farla da padrone. Ha quasi la cattiveria di Dimensions. Quasi.
White Feather sembra una canzone dei T.Rex di Marc Bolan. Assolo compreso. Un irresistibile pezzo semi-funkeggiante che risulta essere uno degli episodi meglio riusciti dell'intero album.
Ma con il passare delle canzoni, purtroppo, si ha la sensazione che Andrew Stockdale e soci abbiano sparato tutte le cartucce troppo presto. Dopo un inizio devastante, l'album si siede un pò troppo, con alcuni pezzi che sembrano addirittura riempitivi.
Le eccezioni sono In The Morning, cavalcata Led Zeppeliana, e la title track, che ridà un pò di brio alla scaletta.
Dalla metà in poi l'album scema incredibilmente, forse anche per scelta del gruppo. Il rock "duro e puro" lascia spazio alla psichedelia per buona parte del lato b di Cosmic Egg.
Il secondo lavoro in studio dei Wolfmother è un buon album, ma le premesse erano ben altre. Cosmic Egg ha alcuni spunti interessanti e alcuni momenti davvero elettrizzanti, ma poi si perde nella mancanza di idee e alternative.
Riff esplosivi e schitarrate cosmiche possono andare bene per un pò, poi però bisogna muoversi, andare avanti.
Credo che i Wolfmother possano e debbano farlo.
Tracklist:
1. California Queen
2. New Moon Rising
3. White Feather
4. Sundial
5. In The Morning
6. 10,000 Feet
7. Cosmic Egg
8. Far Away
9. Pilgrim
10. In The Castle
11. Phoenix
12. Violence Of The Sun
Francesco Ruggeri
martedì 19 gennaio 2010
Cold War Kids - Behave Yourself Ep

mercoledì 13 gennaio 2010
Vampire Weekend - Contra

Parliamoci chiaro fin da subito: sono di parte.
I Vampire Weekend mi fanno impazzire, quindi cercherò di essere il più obiettivo possibile.
Tra gli album in uscita nel 2010, sulla mia agenda era uno di quelli segnati in rosso.
L’ho atteso con trepidante speranza, l’ho immaginato meglio del predecessore.
Spesso, troppo spesso, il secondo album di una band si riduce ad un mero confronto con il precedente.
Il solito giochino questa volta non funziona.
Non si può ridurre tutto alla classica domanda: quale dei due è meglio?
Perché anche adesso che l’ho ascoltato quindici volte, non so la risposta a questa (inutile) domanda.
Ma facciamo un passo indietro.
Grazie al loro Lp di debutto, vicino alla perfezione, i Vampire Weekend erano stati accolti nel 2008 come i salvatori della patria. I nuovi geni della musica alternativa.
Recensioni luccicanti. Apparizioni televisive. Festival estivi.
Ma una discreta fetta di critici musicali e di ascoltatori non sono mai riusciti a comprenderli. Il loro, sicuramente originale, mix di indie-pop e influenze africane non è la cosa più facilmente assimilabile che esiste in commercio.
Quindi, se il primo album non vi è piaciuto, questo allo stesso modo non vi farà impazzire.
Partiamo da Horchata, ad esempio.
La prima traccia di Contra, contaminata da ritmi caraibici, è l’anello di congiunzione tra il precedente lavoro e questo. Sono i Vampire Weekend ai quali eravamo abituati.
Ma già dal secondo pezzo, White Sky, si ingrana un'altra marcia. Ezra Koenig canta di passeggiate nei parchi di Manhattan e di visite pomeridiane al MoMa. E quanto vorresti farti un giro con lui. Rostam Batmanglij costruisce un intricato quanto delicato tappeto di tastiere, e i soavi vocalizzi di Koenig chiudono un pezzo splendido.
Holiday è una veloce e divertente variazione punk, con un ritornello irresistibile ed un mood estivo che, in questo periodo di neve e nebbia, non può che fare bene.
California English è un altro pezzo velocissimo, che magari lascia indifferenti ad un primo ascolto, ma che cresce insistentemente con il tempo.
Grazie alla fulminante sequenza dei brani, il disco riesce a coinvolgere facilmente l’ascoltatore, che viene inondato di sensazioni, molto simili a quelle che scatenava il primo album. Freschezza. Originalità. Melodia. Insomma, musica. Ottima musica.
La capacità di produrre musica di questi quattro ragazzi è sorprendente. Prendete Cousins, il primo singolo estratto. Travolgente è l’unica parola che mi viene in mente. Impossibile rimanere fermi ascoltandola. La batteria di Chris Tomson picchia per tutti i due minuti e venticinque secondi di irresistibile delirio.
Diplomat’s Son, oltre a riprendere i tamburi che hanno reso celebre Cape Cod Kwassa Kwassa, è un chiaro rimando a Joe Strummer, così come Taxi Cab e I Think Ur A Contra, tutti riferimenti espliciti a Sandinista!, album dei Clash.
Contra contiene poche chitarre, ha un suono più ovattato e meno pungente del primo album, senza aver stravolto la formula (vincente) di pezzi come Oxford Comma o A-Punk.
C’è un pizzico di Clash.
Ci sono i tanto celebrati beat africani.
Ci sono i testi educati e collegiali di Ezra Koenig.
Non sono cambiati di una virgola, eppure Contra è proprio un bell’album.
O li odi o li ami.
Io continuo ad amarli.
Alla follia.
Tracklist:
1. Horchata
2. White Sky
3. Holiday
4. California English
5. Taxi Cab
6. Run
7. Cousins
8. Giving Up The Gun
9. Diplomat’s Son
10. I Think Ur A Contra
Francesco Ruggeri
domenica 3 gennaio 2010
Best of 2009
Ecco le mie scelte per il 2009.
Ah, dimenticavo: benvenuto 2010.
Era ora, cazzo.
20 Lp dell'anno
2- Grizzly Bear - Veckatimest
3- Kasabian - West Ryder Pauper Lunatic Asylum
4- Noah And The Whale - The First Days Of Spring
5- The Horrors - Primary Colours
6- Biffy Clyro - Only Revolutions
7- The Veils - Sun Gangs
8- The Boxer Rebellion - Union
9- Manic Street Preachers - Journal For Plague Lovers
10- Jamie T - Kings & Queens
11- Arctic Monkeys - Humbug
12- Them Crooked Vultures - Them Crooked Vultures
13- Julian Plenti - ...is Skyscraper
14- Bob Dylan - Together Through Life
15- Pearl Jam - Backspacer
16- The Decemberists - The Hazards Of Love
17- Various Artists - Dark Was The Night
18- Mumford And Sons - Sigh No More
19- Volcano Choir - Unmap
20- Bon Iver - Blood Bank Ep
- Editors - In This Light And On This Evening
48- Them Crooked Vultures - Elephants